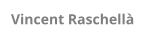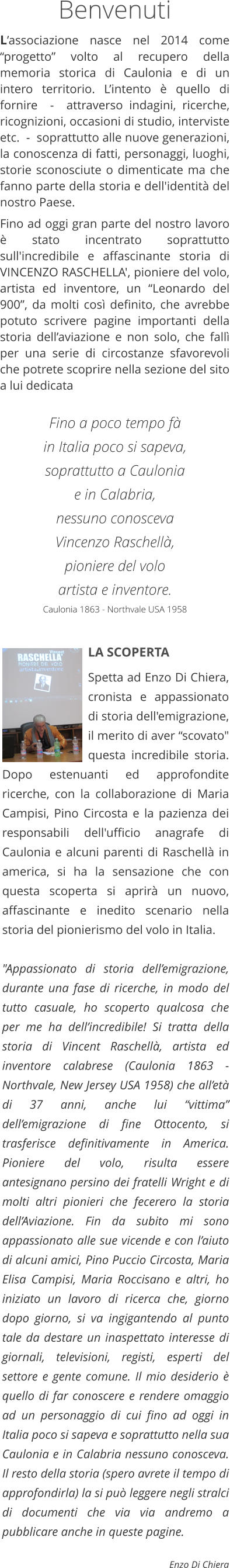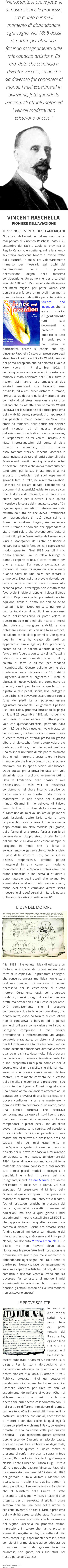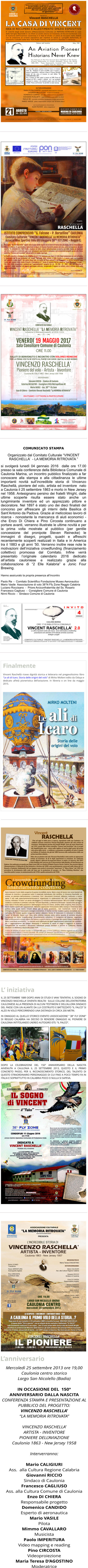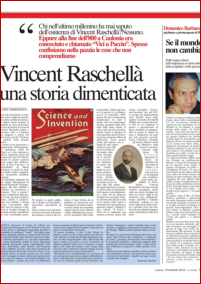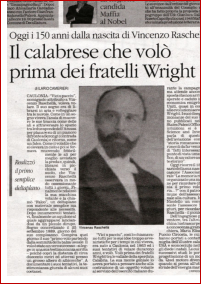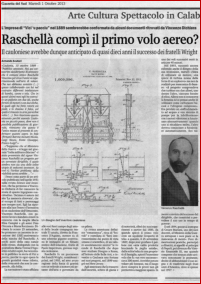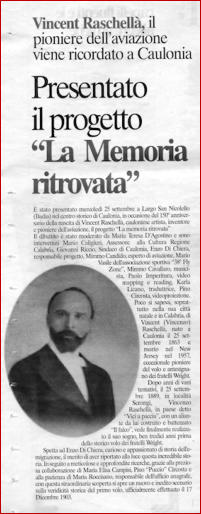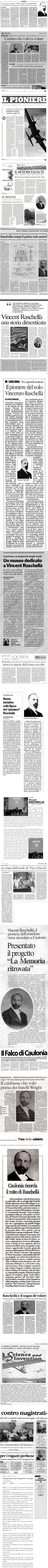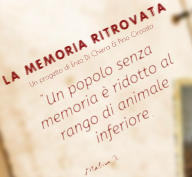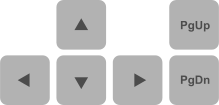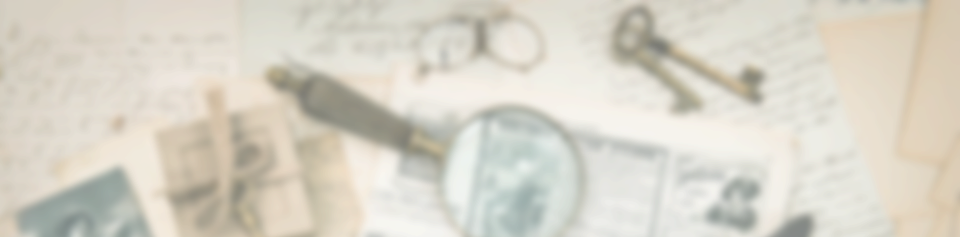
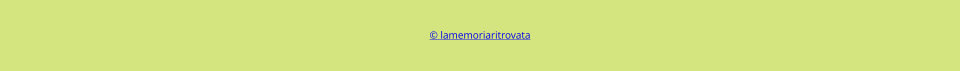


LA SCOPERTA
Spetta ad Enzo Di Chiera, cronista curioso e appassionato di storia dell'emigrazione, il merito di aver "scovato" questa incredibile storia. Dopo estenuanti ed approfondite ricerche, con la collaborazione di Maria Elisa Campisi, Pino Circosta e la pazienza di Maria Roccisano, responsabile dell'ufficio anagrafe, si ha la sensazione che con questa scoperta si aprirà un nuovo, affascinante e inedito scenario nella storia del pionierismo del volo in Italia. "Appassionato di storia dell’emigrazione, durante una fase di ricerche, in modo del tutto casuale, ho scoperto qualcosa che per me ha dell’incredibile! Si tratta della storia di Vincent Raschellà, artista ed inventore calabrese (Caulonia 1863 - Northvale, New Jersey USA 1958) che all’età di 37 anni, anche lui “vittima” dell’emigrazione di fine Ottocento, si trasferisce definitivamente in America. Pioniere del volo, risulta essere antesignano persino dei fratelli Wright e di molti altri pionieri che fecerero la storia dell’Aviazione. Fin da subito mi sono appassionato alle sue vicende e con l’aiuto di alcuni amici, Pino Puccio Circosta, Maria Elisa Campisi, Maria Roccisano e altri, ho iniziato un lavoro di ricerca che, giorno dopo giorno, si va ingigantendo al punto tale da destare un inaspettato interesse di giornali, televisioni, registi, esperti del settore e gente comune. Il mio desiderio è quello di far conoscere e rendere omaggio ad un personaggio di cui fino ad oggi in Italia poco si sapeva e soprattutto nella sua Caulonia e in Calabria nessuno conosceva. Il resto della storia (spero avrete il tempo di approfondirla) la si può leggere negli stralci di documenti che via via andremo a pubblicare anche in queste pagine. Enzo Di Chiera

Benvenuti
L’associazione nasce nel 2014 come “progetto” volto al recupero della memoria storica di Caulonia e di un intero territorio. L’intento è quello di fornire - attraverso indagini, ricerche, ricognizioni, occasioni di studio, interviste etc. - soprattutto alle nuove generazioni, la conoscenza di fatti, personaggi, luoghi, storie sconosciute o dimenticate ma che fanno parte dell'identità del nostro Paese. Fino ad oggi gran parte del nostro lavoro è stato dedicato all'incredibile storia di VINCENZO RASCHELLA', pioniere del volo, artista ed inventore, un “Leonardo del 900” che avrebbe potuto scrivere pagine importanti della storia dell’aviazione e non solo, che fallì per una serie di circostanze sfavorevoli.
“Fino ad oggi in Italia poco si sapeva,
soprattutto nella sua Caulonia e in Calabria,
nessuno conosceva Vincent Raschellà,
pioniere del volo artista e inventore.”
Caulonia 1863 - Northvale, New Jersey 1958


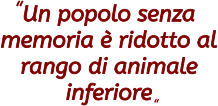
Malcom X
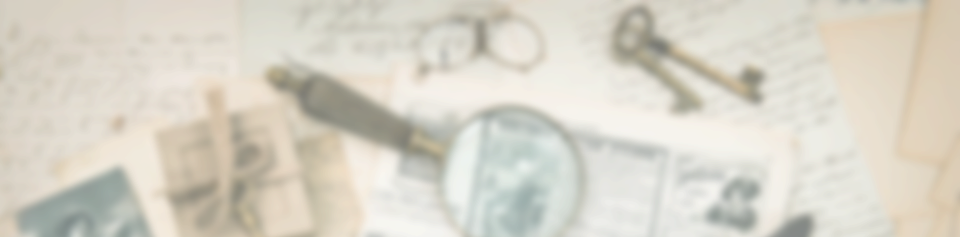
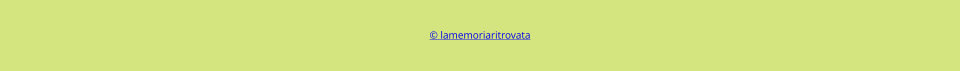
VINCENT RASCHELLA’
PIONIERE DELL'AVIAZIONE
II RICONOSCIMENTO DEGLI AMERICANI
G
li
storici
dell'aviazione
italiana
non
hanno
mai
parlato
di
Vincenzo
Raschellà,
nato
il
25
settembre
del
1863
a
Caulonia,
provincia
di
Reggio
Calabria,
e
spetta
quindi
alla
stampa
scientifica
americana
l'onore
di
averlo
tratto
dalla
oscurità,
in
cui
si
era
volontariamente
immerso,
per
mostrarlo
agli
occhi
dei
contemporanei
come
un
pioniere
dell’aviazione
degno
della
massima
considerazione.
Un
uomo
che,
per
circa
dieci
anni,
dal
1885
al
1895,
si
è
dedicato
alla
ricerca
dei
mezzi
migliori
per
poter
volare,
con
perspicacia
e
fervore
ammirevoli,
non
merita
di
morire
ignorato
da
tutti
e
pertanto
la
rivista
Science
and
Invention
,
che
ha
esaminato
diligentemente
tutti
i
suoi
documenti,
lo
presenta
al
pubblico
di
tutto
il
mondo,
(ed
a
noi
italiani
in
particolare),
perché
si
sappia
che
egli,
Vincenzo
Raschellà
è
stato
un
precursore
degli
stessi
fratelli
Wilbur
ed
Orville
Wright,
creatori
del
primo
aeroplano
che
ha
spiccato
il
volo
a
Kitty
Hawk
il
17
dicembre
1903.
Il
venticinquesimo
anniversario
di
questo
volo
famoso
è
stato
celebrato
nel
1928
e
tutte
le
nazioni
civili
hanno
reso
omaggio
ai
due
aviatori
americani,
che
l'avevano
reso
possibile,
ed
a
così
breve
distanza
di
tempo,
(1930)
,
senza
detrarre
nulla
al
merito
dei
loro
connazionali,
gli
stessi
americani
esaltano
un
italiano
che
diciassette
anni
prima
dei
Wright
lavorava
per
la
soluzione
del
difficile
problema
della
viabilità
aerea,
servendosi
di
apparecchi
più
pesanti
e
meno
pesanti
dell'aria.
Una
storia
da
romanzo.
Nella
notizia
che
Science
and
Invention
dà
di
questo
pioniere
dell'aviazione,
si
parla
di
«storia
romanzesca»,
di
«esperimenti
da
far
venire
i
brividi»
e
di
«fatti
interessantissimi
dal
punto
di
vista
umano
e
scientifico,
di
un
valore
assolutamente
storico».
Vincent
Raschellà,
è
stato
invitato
a
visitare
gli
uffici
editoriali
della
Science
and
Invention
ed
è
qui
che
si
è
deciso
a
spezzare
il
silenzio
che
aveva
mantenuto
per
tanti
anni,
per
la
sua
innata
modestia.
Ha
esposto
i
particolari
dei
suoi
esperimenti
giovanili
fatti
in
Italia,
nella
remota
Calabria.
Raschellà
ha
parlato
di
fatti,
corroborati
da
documenti
di
autenticità
evidente,
senza
alcun
fine
di
gloria
o
di
notorietà,
e
bastano
le
sue
stesse
parole
per
illustrare
il
suo
spirito
inventivo
e
le
cause
del
mancato
successo
"Da
ragazzo,
quasi
per
istinto
naturale
era
stato
attratto
da
tutto
ciò
che
aveva
un'attinenza
con
l'aeronautica".
Si
recò
giovanissimo
a
Roma
per
studiare
disegno,
ma
impiegava
tutto
il
tempo
disponibile
per
apprendere
la
vita
di
tutti
coloro
che
avevano
contribuito
ai
primi
sviluppi
dell'aeronautica,
da
Leonardo
da
Vinci
a
Montgolfier
da
Pilatre
de
Rozier
a
Nadar.
Sui
tentativi
fatti,
egli
si
è
espresso
nel
modo
seguente:
“Nel
1885
costruii
il
mio
primo
aquilone.
Era
un
telaio
bislungo
di
bambù
ricoperto
di
tela,
di
circa
tre
metri
per
uno
e
mezzo.
Dal
centro
penzolava
un
trapezio,
al
quale
mi
aggrappai
con
le
mani
quando
saltai
da
una
balza
per
tentare
il
primo
volo.
Descrissi
una
breve
traiettoria
per
terra
e
caddi
in
piedi
a
breve
distanza.
Alla
seconda
prova
l'atterraggio
non
è
stato
tanto
favorevole;
il
telaio
si
ruppe
e
mi
slogai
il
piede
sinistro.
Dopo
qualche
tempo
costruii
un
altro
aquilone,
simile
al
primo,
ma
non
ho
avuto
risultati
migliori.
Dopo
un
certo
numero
di
vani
tentativi
con
gli
aquiloni,
mi
sono
reso
conto
dell'impossibilità
di
poter
volare
in
questo
modo
e
mi
diedi
alla
ricerca
di
mezzi
che
offrissero
maggiore
stabilità
e
che
potessero
essere
usati
con
una
forza
motrice.
«Il
pallone
con
le
ali
di
pipistrello»
Con
questa
idea
in
mente
ho
creato
più
tardi
un
apparecchio
simile
agli
aquiloni
precedenti,
sostenuto
da
un
pallone
a
forma
di
sigaro,
fatto
di
tela
foderata
con
carta
velina.
Trattai
la
tela
con
una
soluzione
di
cloruro
di
cilicio,
solfato
di
ferro
e
allume,
per
renderla
incombustibile.
Questo
pallone
con
le
due
punte
acuminate
misurava
circa
13
metri
di
lunghezza,
4
metri
di
larghezza
e
3
metri
di
altezza.
II
nuovo
velivolo
era
completato
da
due
ali,
simili
per
forma
a
quelle
di
un
pipistrello,
due
pedali,
sedile,
leva,
pulegge
e
due
eliche,
che
dovevano
essere
mosse
con
la
forza
dei
piedi.
Le
ali
potevano
essere
aggiustate
curvandole.
Per
gonfiare
il
pallone
usai
aria
calda,
prodotta
bruciando
la
paglia
umida.
Il
25
settembre
1889,
giorno
del
mio
ventiseesimo
compleanno,
ho
fatto
il
primo
volo
con
quest'apparecchio,
partendo
dalla
sommità
della
balza
usuale.
Il
volo
è
stato
un
vero
successo,
poiché
coprii
la
distanza
di
circa
duecento
metri
ed
atterrai
presso
un
grosso
albero
di
albicocche.
Avrei
potuto
volare
più
lontano,
ma
il
luogo
dei
miei
esperimenti
era
una
collina
di
un
fondo
di
mio
padre,
chiamato
Scrongi,
ed
il
terreno
circostante
era
inclinato
in
modo
tale
che
l'unico
punto
su
cui
si
poteva
atterrare
era
lo
spazio
vicino
all'albicocco.
Dopo
questa
prima
prova
ho
fatto
altri
voli,
alcuni
dei
quali
riuscirono
veramente
ottimi.
Data
la
limitazione
dello
spazio
a
mia
disposizione,
i
miei
voli
di
resistenza
consistevano
nel
girare
intorno
descrivendo
piccoli
cerchi
ed
in
questo
modo
riuscii
a
mantenermi
in
aria
anche
per
quaranta
minuti.
Chiamai
il
mio
velivolo:
«Il
Falco».
Verso
la
fine
di
ottobre,
dello
stesso
anno,
durante
uno
dei
miei
voli
un
lato
del
pallone
si
apri,
lasciando
uscire
l'aria
calda,
e
tutto
l'apparecchio
cascò
a
terra.
Immediatamente
dopo
costruii
un
altro
modello
più
grosso,
della
forma
di
una
grossa
farfalla,
con
le
ali
coperte
da
un
doppio
strato
di
tela.
Tanto
il
pallone
che
le
ali
dovevano
essere
riempiti
di
idrogeno,
in
modo
che
la
forza
di
sollevamento
del
gas
avrebbe
controbilanciato
il
peso
della
struttura.
Cosi,
con
le
sue
ali
distese,
l'apparecchio,
avrebbe
potuto
mantenersi
in
aria
come
un
moderno
monoplano.
In
quell'epoca
i
motori
aerei
non
erano
conosciuti,
quindi
cercai
di
studiare
il
dono
naturale
degli
uccelli
che
volano.
Ho
esaminato
che
alcuni
uccelli
quando
volano,
fanno
evoluzioni
e
cambiano
altezza
senza
muovere
le
ali
e
così
cercai
di
imitare
la
natura
utilizzando
le
varie
correnti
dei venti”.
L'IDEA DEL MOTORE
“Nei
1893
mi
è
venuta
l'idea
di
utilizzare
un
motore,
una
specie
di
turbina
mossa
dalla
forza
di
un
esplosivo.
Ho
preparato
il
disegno,
che
conservo
ancora,
ma
l'idea
non
è
stata
realizzata
perché
mi
mancava
il
denaro
necessario
per
la
costruzione
di
questo
motore.
Certamente
oggi,
col
progresso
moderno,
i
miei
disegni
dovrebbero
essere
rifatti,
ma
ormai
non
è
più
il
caso
di
parlarne.
Dirò
semplicemente
che
il
progetto
comprendeva
due
turbine
con
due
alberi,
uno
dentro
l'altro,
ciascuno
fornito
di
elica.
Allora
non
si
conosceva
la
benzina
ed
io
pensai
anche
di
utilizzare
come
carburante
l'alcool
o
l'idrogeno
compresso.
I
miei
disegni
prevedevano
il
raffreddamento
ad
acqua,
serbatoio
e
radiatore,
un
sistema
di
pompe
per
la
lubrificazione
e
tante
altre
cose.
I
motori
erano
destinati
a
funzionare
alternativamente:
quando
uno
si
riscaldava
molto,
l'altro
doveva
cominciare
a
funzionare
automaticamente.
Ho
quindi
preparato
i
mici
piani
completi
per
la
costruzione
di
un
dirigibile,
che
chiamai
«Ital-aereo
»,
che
doveva
essere
mosso
da
tale
motore.
Ero
talmente
convinto
del
successo
del
dirigibile,
che
cominciai
a
prevedere
il
suo
uso
in
tempo
di
guerra.
E
così
disegnai
anche
una
bomba
aerea,
da
lanciare
attaccata
ad
un
paracadute,
provvista
di
una
lancia
fissa,
che
doveva
conficcarsi
a
terra
e
mantenere
la
bomba
all'altezza
del
torace
di
un
uomo,
come
una
piccola
fortezza
che
scaricava
centocinquanta
pallottole
in
tutti
i
sensi
e
poi,
per
mezzo
di
una
carica
separata,
esplodeva
rompendosi
in
piccoli
pezzi.
Fino
ad
allora
avevo
mantenuto
tutto
segréto.
Ad
eccezione
di
alcuni
intimi
amici,
dei
parenti
e
di
mia
madre,
che
mi
aiutava
a
cucire
le
tele,
nessuno
sapeva
nulla
dei
miei
esperimenti.
In
quell'epoca
la
gente
mi
avrebbe
messo
in
ridicolo
per
le
prove
che
facevo
e
mi
avrebbe
considerato
come
un
pazzo.
Nel
dicembre
del
1894
ritenni
di
avere
accumulato
sufficiente
materiale
per
farmi
conoscere
e
cosi
raccolsi
tutti
i
miei
piccoli
modelli,
i
disegni
e
le
descrizioni
e
chiesi
il
parere
del
mio
insegnante,
il
prof.
Cesare
Mariani
,
presidente
dell'Istituto
di
Belle
Arti
a
Roma.
Col
suo
appoggio
fui
presentato
al
Ministro
della
Guerra,
al
quale
sottoposi
i
miei
piani
e
la
mancanza
di
mezzi.
Ebbi
interviste
e
dibattiti,
feci
dimostrazioni
pratiche
in
presenza
dei
tecnici
governativi,
ricevetti
promesse
ed
adulazioni,
ma
fino
a
quel
giorno
i
miei
esperimenti
mi
erano
costali
circa
23.500
lire,
che
rappresentavano
in
quell'epoca
una
forte
somma
di
denaro.
Poiché
ero
rimasto
senza
fondi
disponibili,
mi
rivolsi,
su
indicazione
del
mio
ex
professore,
al
Governo
e
al
Principe
di
Napoli,
poi
divenuto
Vittorio
Emanuele
III
Re
d'Italia,
ma
non
ricevetti
alcun
aiuto.
Nonostante
le
prove
fatte,
le
dimostrazioni
e
le
promesse,
era
giunto
per
me
il
momento
di
abbandonare
ogni
sogno.
Nel
1898
decisi
di
partire
per
l'America,
facendo
assegnamento
sullo
mie
capacità
artistiche.
Ed
ora,
dato
che
comincio
a
diventar
vecchio,
credo
che
sia
doveroso
far
conoscere
al
mondo
i
miei
esperimenti
in
aviazione,
fatti quando la benzina, gli attuali motori ed i velivoli moderni non esistevano ancora”.
LE PROVE SCRITTE
In
quanto
ai
documenti
scritti,
che
fanno
fede
dei
primi
tentativi
del
Raschellà,
egli
non
li
ha
tenuti
nascosti
e
li
ha
esibiti
per
essere
pubblicati
in
facsimile,
assieme
ai
suoi
disegni.
Per
la
storia
riproduciamo
una
dichiarazione
rilasciata
da
quattro
amici
del
nostro
pioniere:
“Caulonia,
10
ottobre
1889.
«
Pubblico
attestato.
«Noi
qui
sottoscritti
desideriamo
di
attestare
che
il
comune
amico
Raschellà
Vincenzo
per
circa
tre
anni
va
esperimentando
nell'arte
di
volare.
«Che
noi
abbiamo
assistito
a
quasi
tutte
le
sue
operazioni,
anzi
spesso
collaborammo
con
lui
nel
costruire
differenti
intelaiature
di
bambù,
canne
e
tela.
«Che
in
questi
ultimi
mesi
egli
ha
costruito
un
pallone
con
due
ali,
anche
fornito
di
motori
e
con
due
eliche,
le
quali
egli
fa
rotare
coi
piedi,
e
lo
chiama
il
Falco,
col
quale
è
rimasto
in
aria
parecchie
volte
per
qualche
distanza.
«Noi
rilasciamo
questo
attestato
perché
essendo
Caulonia
un
piccolo
paese,
dove
non
è
possibile
pubblicazione
di
giornale,
riteniamo
che
questo
è
l'unico
mezzo
al
presente
di
confermare
quanto
sopra.
In
fede
(firmati)
Barone
Asciutti
Nicola,
Luigi
Giuseppe
Nescis,
Fonte
Giuseppe,
Franco
Luigi.
Oltre
a
ciò,
che
potrebbe
bastare,
Vincenzo
Raschellà
ha
conservato
il
numero
del
22
Gennaio
1895
del
giornale
“L'Italia
Militare
e
Marina”,
nel
quale,
sotto
il
titolo
«
La
viabilità
aerea”
è
stato
pubblicato
il
seguente
testo:
«
Sappiamo
che
al
Ministero
della
Guerra
è
stato
presentato
dal
Signor
Vincenzo
Raschellà
un
progetto
per
un
aerostato
dirigibile,
il
quale
sembra
non
sia
una
delle
solite
utopie
di
sedicenti
inventori.
Se
cosi
è,
l'arduo
problema
della
viabilità
aerea
sarebbe
stato
finalmente
risolto.
«Ci
viene
assicurato
che
la
invenzione
del
Signor
Raschellà
ha
prodotto
ottima,
impressione
in
coloro
che
hanno
preso
in
esame
il
progetto,
e
che,
fra
sette
od
otto
mesi,
compiuti
gli
esperimenti
necessari,
potrà
compiersi
il
primo
viaggio
aereo,
adoperando
il
motore
trovato
dal
giovane
inventore
calabrese,
non
ignoto,
per
i
suoi
studi,
nel
nostro
parco aerostatico».
New York, 5 maggio 1931
FONTE “LA STAMPA”
“Nonostante le prove fatte, le dimostrazioni e le
promesse, era giunto per me il momento di
abbandonare ogni sogno. Nel 1898 decisi di partire per
l'America, facendo assegnamento sulle mie capacità
artistiche. Ed ora, dato che comincio a diventar
vecchio, credo che sia doveroso far conoscere al mondo
i miei esperimenti in aviazione, fatti quando la benzina,
gli attuali motori ed i velivoli moderni
non esistevano ancora.”
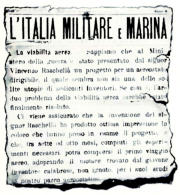
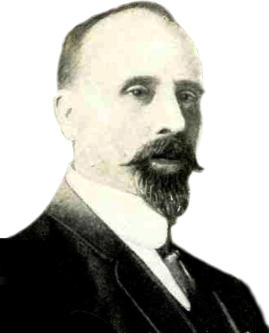
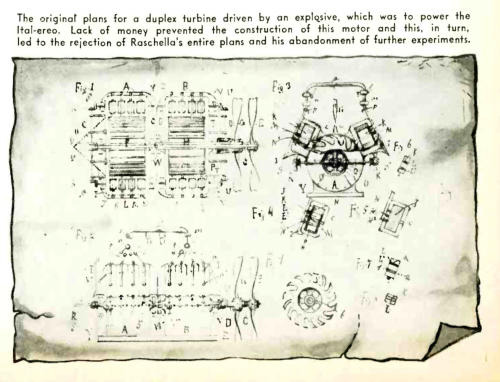
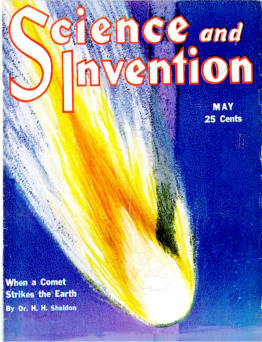


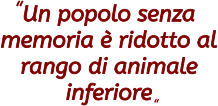
Malcom X
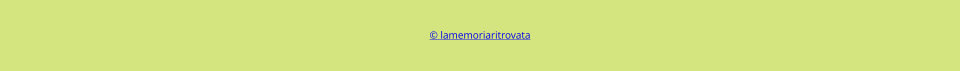
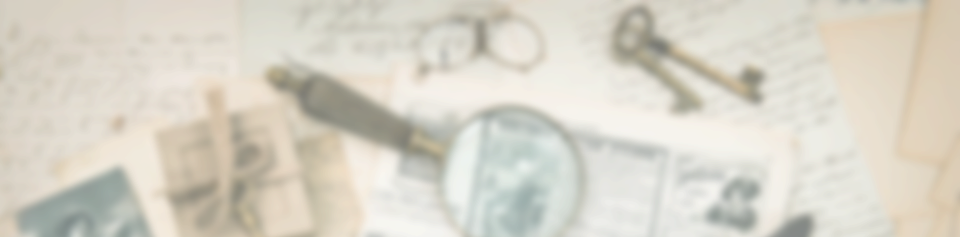
Iniziative
Novità, appuntamenti, iniziative ed eventi su Vincent Raschellà.

L’anniversario
Mercoledì 25 settembre 2013 ore 19,00 Caulonia centro storico Largo San Nicolello (Badia) IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA CONFERENZA STAMPA E PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEL PROGETTO: VINCENZO RASCHELLA’ “LA MEMORIA RITROVATA” VINCENZO RASCHELLA’ ARTISTA - INVENTORE PIONIERE DELL’AVIAZIONE Caulonia 1863 - New Jersey 1958 Interverranno: Mario CALIGIURI Ass. alla Cultura Regione Calabria Giovanni RICCIO Sindaco di Caulonia Francesco CAGLIUSO Ass. alla Cultura Comune di Caulonia Enzo DI CHIERA Responsabile progetto Domenico CANDIDO Esperto di aeronautica Mario VASILE Pilota Mimmo CAVALLARO Musicista Paolo IMPERITURA Video mapping e reading Pino CIRCOSTA Videoproiezione Maria Teresa D’AGOSTINO ModeratriceL’ iniziativa
IL
25
SETTEMBRE
1889
DOPO
ANNI
DI
STUDI
E
VANI
TENTATIVI,
IL
SOGNO
DI
VINCENZO
RASCHELLA’
DIVENTA
REALTA!
SULLE
COLLINE
DELL’ENTROTERRA
CAULONIESE
ALLA
PRESENZA
DI
ALCUNI
TESTIMONI
E
DELL’ALLORA
SINDACO
DEL
PAESE
CON
UN
ALIANTE
DA
LUI
COSTRUITO
E
BATTEZZATO
“IL
FALCO”
SI
ALZO IN VOLO PERCORRENDO UNA DISTANZA DI CIRCA 200 METRI.
IN OMAGGIO AL QUELLO STORICO EVENTO L’ASSOCIAZIONE “ 38° FLY ZONE” DI REGGIO CALABRIA HA DECISO DI RENDERE OMAGGIO AL PIONIERE DI CAULONIA INTITOLANDO L’AEREO AUTOGIRO 07S: “IL FALCO”. DOPO LA CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AVVENUTA A CAULONIA IL 25 SETTEMBRE 2013, QUESTO E IL PRIMO CONCRETO PASSO, PER IL RICONOSCIMENTO STORICO, DEL TALENTO DI QUESTO STRAORDINARIO PERSONAGGIO DI CUI FINO A POCO TEMPO FA IN ITALIA E SOPRATTUTTO IN CALABRIA POCO O NULLA SI SAPEVA.Finalmente
Vincent
Raschellà
riceve
dignità
storica
e
letteraria
nel
pregevolissimo
libro
"Le
ali
di
Icaro.
Storia
delle
origini
del
volo"
di
Mirko
Molteni
edito
da
Odoya
e
dedicato
all'età
pioneristica
dell'aviazione.
In
libreria
e
on
line
da
maggio
2015.

COMUNICATO STAMPA
Organizzato dal Comitato Culturale “VINCENT RASCHELLA’ - LA MEMORIA RITROVATA ”
si
svolgerà
lunedì
04
gennaio
2016
dalle
ore
17.00
presso
la
sala
conferenze
della
Biblioteca
Comunale
di
Caulonia
Marina,
un
incontro
pubblico
finalizzato
a
far
conoscere
alla
stampa
e
alla
cittadinanza
le
ultime
importanti
novità
sull’incredibile
storia
di
Vincenzo
Raschellà,
pioniere
del
volo,
artista
ed
inventore
nato
a
Caulonia
il
25
settembre
1863
e
morto
in
New
Jersey
nel
1958.
Antesignano
persino
dei
fratelli
Wright,
dalle
ultime
scoperte
risulta
essere
stato
anche
un
lungimirante
inventore
ed
un
apprezzato
pittore
e
decoratore.
Nel
1897
è
stato
uno
dei
dieci
finalisti
del
concorso
per
affrescare
gli
interni
della
Basilica
di
Sant’Antonio
da
Padova.
Grazie
al
meticoloso
lavoro
di
ricerca
-
nonostante
la
mancanza
di
aiuti
economici
-
che
Enzo
Di
Chiera
e
Pino
Circosta
continuano
a
portare
avanti,
verranno
illustrate
le
ultime
novità
e
per
la
prima
volta
mostrate
al
pubblico
(per
gentile
concessione
del
pronipote
Steven
Reinecke)
le
immagini
di
disegni,
progetti,
quadri
e
affreschi
recentemente
scoperti
realizzati
in
Italia
e
in
America
tra
il
1883
e
gli
anni
’50.
Verranno
inoltre
rese
note
le
motivazioni
dell’iniziativa
crowdfunding
(finanziamento
collettivo)
promossa
dal
Comitato.
Infine
verrà
presentato
l’originale
calendario
2016
dedicato
all’artista
cauloniese
e
realizzato grazie alla collaborazione di “2 Elle Kalabria” e Jonic Four Brewing.
Hanno assicurato la propria presenza all’incontro
Paolo Re - Comitato Scientifico Fondazione Museo Aeronautico
Mario Vasile Associazione di volo 38°N Ffy Zone Reggio Calabria
Luciano Roccisano - Priore Arciconfraternita del Ss. Rosario
Francesco Cagliuso - Consigliere Comune di Caulonia
Ninni Riccio - Sindaco Comune di Caulonia
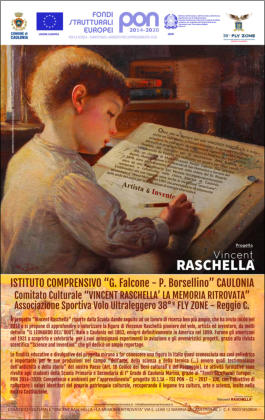

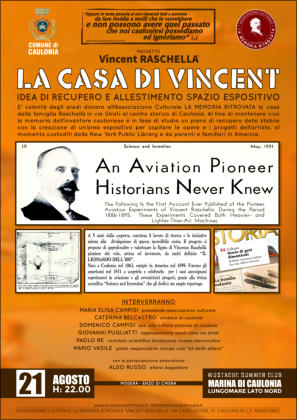


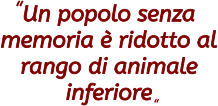
Malcom X
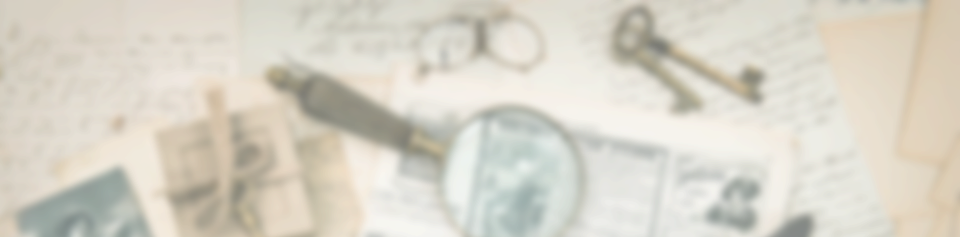
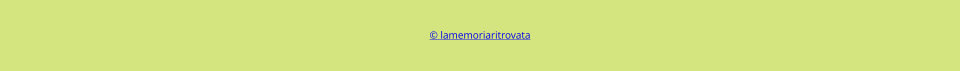
Gallery
Vincenzo
Raschellà
è
stato
anche
un
apprezzato
artista
ed
inventore.
A
parte
gli
esperimenti
in
aviazione,
ha
realizzato
quadri,
dipinti
e
affreschi
di
pregevole
fattura,
in
Italia
e
in
America.
Nel
1894
ha
partecipato
alla
decorazione
del
Duomo
di
Ascoli
Piceno,
con
affreschi
del
suo
Maestro
Cesare
Mariani.
Ha
realizzato
un
quadro
per
Papa
Leone
XIII.
Nel
1897
è
stato
finalista
del
concorso
per
la
decorazione
della
Basilica
di
Sant’Antonio
da
Padova.
Suo
uno
splendido
ritratto
icona
di
Madre
Frances
Xavier
Cabrini,
la
santa
degli
emigrati
italiani
in
America.
Prima
di
emigrare
definitivamente
negli
Stati
Uniti
ha
voluto
lasciare
traccia
della
sua
arte
anche
a
Caulonia,
realizzando
due
bellissimi
dipinti,
l’Annunciazione
e
il
Miracolo
di
San
Domenico
a
Soriano
(1898),
per
la
chiesa
del
Ss.
Rosario
e
una
pregevole
tela
raffigurante
San
Michele
Arcangelo
-
recentemente
restaurata
-
per
l’altare
dell’omonima
chiesa.
Intensa
e
di
grande
pregio
è
la
produzione
“americana”
di
cui
ancora oggi è facile trovare traccia su prestigiose case d’asta e in collezioni private.
Vincent Raschellà Artista
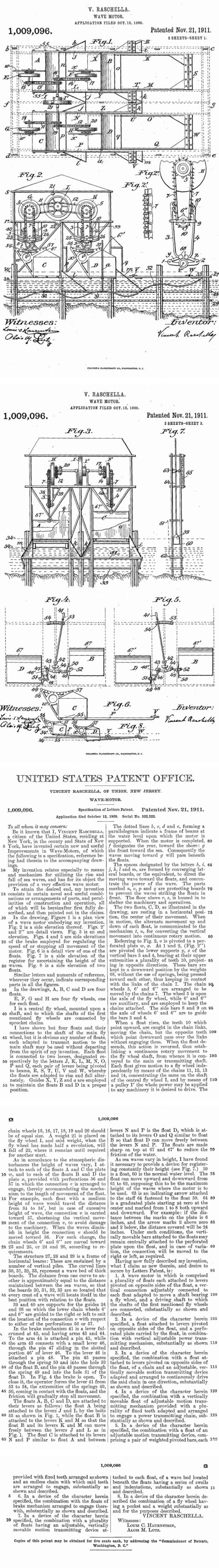
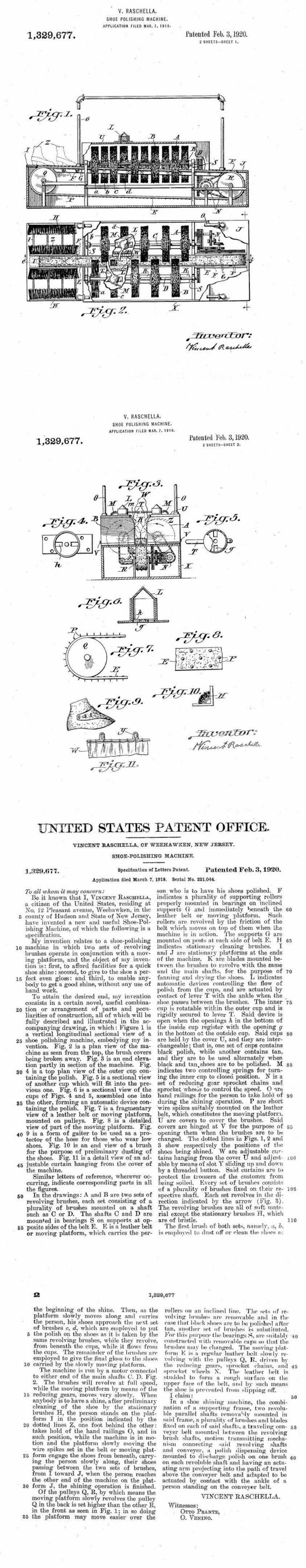
Shoe Cleaning and Polishing Machine
1918
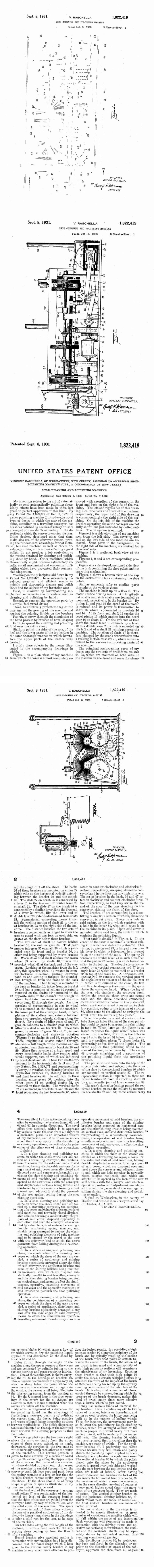
Vincent Raschellà Inventore
Il grande sogno di Raschellà era la realizzazione del motore a turbina da applicare ai suoi aerei e dirigibili. Gli fu
promesso aiuto dal principe di Napoli Vittorio Emanuele (poi diventato Re d’Italia) e dal Governo italiano. Le
promesse disattese e il mancato aiuto economico lo convinsero ad abbandonare gli esperimenti in aviazione che
fino ad allora gli erano costati oltre 27.500 mila lire, per l’epoca un’ingente somma di denaro. Frustrato e
scoraggiato decise di emigrare nel New Jersey facendo affidamento sulle sue capacità tecniche ed artistiche.
Raschellà in America continuò a coltivare la passione per l’aeronautica ma si dedicò prevalentemente alla pittura
e alla scienza. Della sua vasta produzione fanno spicco le invenzioni, brevettate, tra le quali il pale eoliche e il
“Wave Motor” del 1909 che prevedeva lo sfruttamento del moto delle onde del mare per la produzione di energia
alternativa. Progetti ed esperimenti che in Europa e in Italia incominciano a svilupparsi oltre un secolo dopo!
Shoe Cleaning and Polishing Machine
1928
Wave Motor
1908
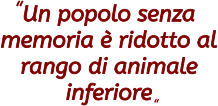
Malcom X



Gallery
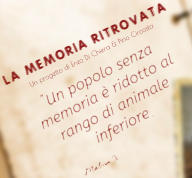


Vincenzo
Raschellà
è
stato
anche
un
apprezzato
artista
ed
inventore.
A
parte
gli
esperimenti
in
aviazione,
ha
realizzato
quadri,
dipinti
e
affreschi
di
pregevole
fattura,
in
Italia
e
in
America.
Nel
1894
ha
partecipato
alla
decorazione
del
Duomo
di
Ascoli
Piceno,
con
affreschi
del
suo
Maestro
Cesare
Mariani.
Ha
realizzato
un
quadro
per
Papa
Leone
XIII.
Nel
1897
è
stato
finalista
del
concorso
per
la
decorazione
della
Basilica
di
Sant’Antonio
da
Padova.
Suo
uno
splendido
ritratto
icona
di
Madre
Frances
Xavier
Cabrini,
la
santa
degli
emigrati
italiani
in
America.
Prima
di
emigrare
definitivamente
negli
Stati
Uniti
ha
voluto
lasciare
traccia
della
sua
arte
anche
a
Caulonia,
realizzando
due
bellissimi
dipinti,
l’Annunciazione
e
il
Miracolo
di
San
Domenico
a
Soriano
(1898),
per
la
chiesa
del
Ss.
Rosario
e
una
pregevole
tela
raffigurante
San
Michele
Arcangelo
-
recentemente
restaurata
-
per
l’altare
dell’omonima
chiesa.
Intensa
e
di
grande
pregio
è
la
produzione
“americana”
di
cui
ancora
oggi
è
facile
trovare
traccia
su
prestigiose
case
d’asta
e
in
collezioni private.
Vincent Raschellà Artista
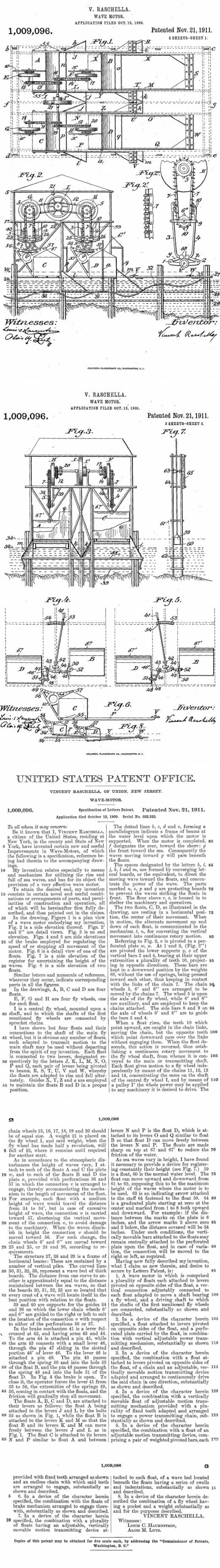
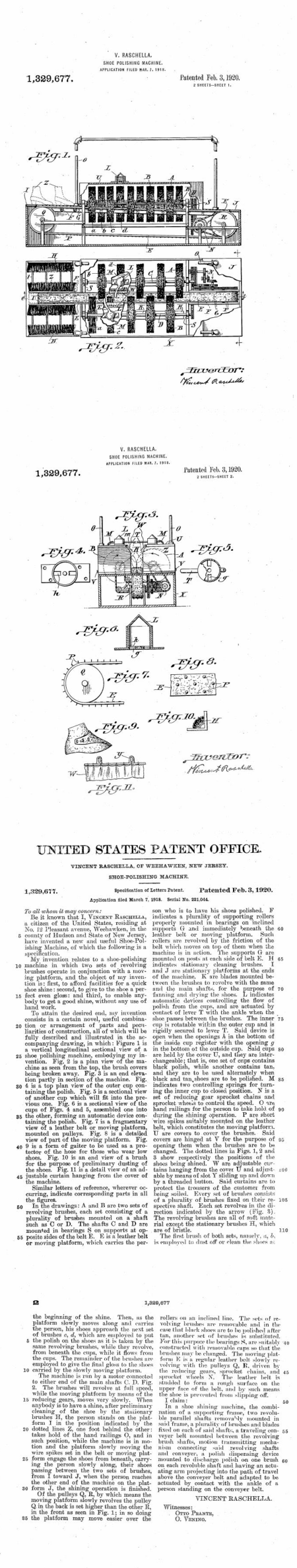
Shoe Cleaning and Polishing Machine
1918
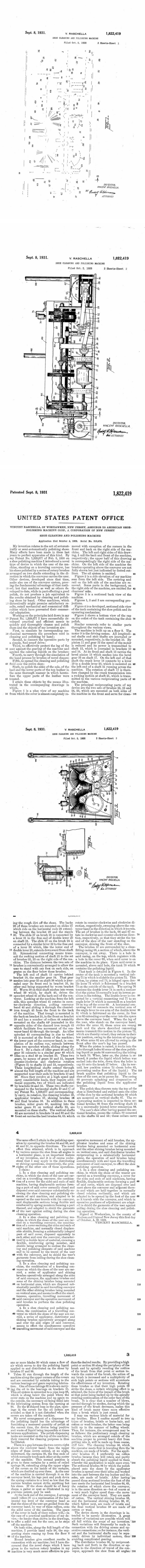
Vincent Raschellà Inventore
Il
grande
sogno
di
Raschellà
era
la
realizzazione
del
motore
da
applicare
ai
suoi
aerei
e
dirigibili.
Gli
fu
promesso
aiuto
dal
principe
di
Napoli
Vittorio
Emanuele
(poi
diventato
Re
d’Italia)
e
dal
Governo
italiano.
Le
promesse
disattese
e
il
mancato
aiuto
economico
lo
convinsero
ad
abbandonare
gli
esperimenti
in
aviazione
che
fino
ad
allora
gli
erano
costati
oltre
27.500
mila
lire,
per
l’epoca
un’ingente
somma
di
denaro.
Frustrato
e
scoraggiato
decise
di
emigrare
nel
New
Jersey
facendo
affidamento
sulle
sue
capacità
tecniche
ed
artistiche.
Raschellà
in
America
continuò
a
coltivare
la
passione
per
l’aeronautica
ma
si
dedicò
prevalentemente
alla
pittura
e
alla
scienza.
Della
sua
vasta
produzione
fanno
spicco
le
invenzioni,
brevettate,
tra
le
quali
il
pale
eoliche
e
il
“Wave
Motor”
del
1909
che
prevedeva
lo
sfruttamento
del
moto
delle
onde
del
mare
per
la
produzione
di
energia
alternativa.
Progetti
ed
esperimenti
che
in
Europa
e
in
Italia
incominciano
a
svilupparsi
oltre
un
secolo dopo!
Shoe Cleaning and Polishing Machine
1928
Wave Motor
1908
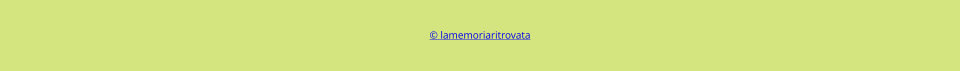
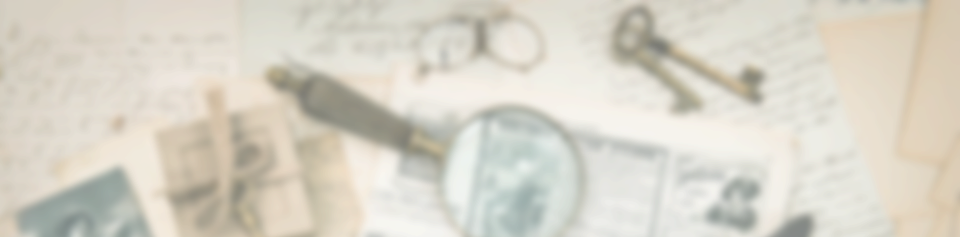
L’Associazione
Associazione Culturale
“LA MEMORIA RITROVATA”
Vincent Raschellà
Premesso che
Il 25/ 09/ 2014 a Caulonia è stato costituito il Comitato Culturale “VINCENT RASCHELLA’ LA MEMORIA RITROVATA” per far conoscere la figura di
Vincenzo Raschellà nato a Caulonia nel 1863 e morto a Northvale, New Jersey 1958, artista, inventore, pioniere del volo; In questi anni il Comitato ha recuperato
una importante pagina di storia dell’Aviazione grazie a questo straordinario personaggio, fino ad oggi sconosciuto, portandolo alla ribalta, grazie ad intense ed
approfondite ricerche svolte sul web, attraverso indagini, occasioni di studio, interviste e documenti.
In seguito
Nel 2017 è stata costituita tra i comparenti, in qualità di soci fondatori, e tra quanti vorranno aderire in seguito a norma dell’art. 3 dello Statuto, una associazione
culturale, apolitica e senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, avente la seguente denominazione:
“LA MEMORIA RITROVATA - VINCENT RASCHELLA’ ”
L’associazione è una libera aggregazione con finalità sociali e culturali di persone fisiche e giuridiche apolitica, apartitica e aconfessionale e senza scopo di
lucro. con durata illimitata;
L’Associazione ha sede in Caulonia Marina (RC) Via Castelvetere n. 31;
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, tra l’altro, la figura di Vincent (Vincenzo) Raschellà: artista, inventore e pioniere del volo, diffondendo la cultura
aeronautica, storica e artistica, e contribuire anche per suo tramite alla promozione e valorizzazione del Centro Storico di Caulonia e del suo territorio;
Organizzare spazi espositivi, allestimenti, manifestazioni, progetti e spettacoli, conferenze, convegni, dibattiti, iniziative editoriali, scambi artistico-culturali
nazionali ed internazionali, anche assumendo, ogni correlata iniziativa utile e necessaria nei riguardi di tutti gli enti, con altre associazioni, imprese pubbliche e
private, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, università, collettività.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da donazioni, lasciti siano essi di fonte privata e/o pubblica e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono
costituite dai contributi dei soci promotori, dei sottoscrittori, o di terzi, da sovvenzioni e finanziamenti dello Stato e/o europei e di enti pubblici o privati; al
fine di raggiungere lo scopo sociale l’Associazione può richiedere finanziamenti e sostentamento ad enti pubblici e privati.
Consiglio Direttivo:
BIANCOSPINO Cinzia
CIRCOSTA Giuseppe
DICHIERA Vincenzo
PENNA Adriana
PISCIONERI Romolo
RE Paolo
VASILE Mario Francesco
Cariche
Presidente
CIRCOSTA Giuseppe
Vice presidente
BIANCOSPINO Cinzia
Segretario
VASILE Mario Francesco
Tesoriere
RE Paolo
Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni
DI CHIERA Vincenzo
Responsabile Ricerche
Ass. Culturale La Memoria Rirtovata


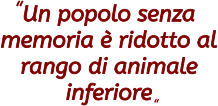
Malcom X

L’Associazione
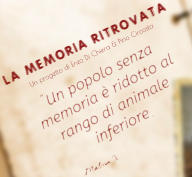


Associazione Culturale
“LA MEMORIA RITROVATA”
Vincent Raschellà
premesso che
Il 25/ 09/ 2014 a Caulonia è stato costituito il Comitato Culturale
“VINCENT RASCHELLA’ LA MEMORIA RITROVATA” per far
conoscere la figura di Vincenzo Raschellà nato a Caulonia nel 1863 e
morto a Northvale, New Jersey 1958, artista, inventore, pioniere del
volo; In questi anni il Comitato ha recuperato una importante pagina di
storia dell’Aviazione grazie a questo straordinario personaggio, fino ad
oggi sconosciuto, portandolo alla ribalta, grazie ad intense ed
approfondite ricerche svolte sul web, attraverso indagini, occasioni di
studio, interviste e documenti.
In seguito
Nel 2017 è stata costituita tra i comparenti, in qualità di soci fondatori,
e tra quanti vorranno aderire in seguito a norma dell’art. 3 dello Statuto,
una associazione culturale, apolitica e senza scopo di lucro, con durata
illimitata nel tempo, avente la seguente denominazione:
“LA MEMORIA RITROVATA - VINCENT RASCHELLA’ ”
L’associazione è una libera aggregazione con finalità sociali e culturali
di persone fisiche e giuridiche apolitica, apartitica e aconfessionale e
senza scopo di lucro. con durata illimitata;
L’Associazione ha sede in Caulonia Marina (RC) Via Castelvetere n.
31;
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, tra l’altro, la figura di
Vincent (Vincenzo) Raschellà: artista, inventore e pioniere del volo,
diffondendo la cultura aeronautica, storica e artistica, e contribuire
anche per suo tramite alla promozione e valorizzazione del Centro
Storico di Caulonia e del suo territorio;
Organizzare spazi espositivi, allestimenti, manifestazioni, progetti e
spettacoli, conferenze, convegni, dibattiti, iniziative editoriali, scambi
artistico-culturali nazionali ed internazionali, anche assumendo, ogni
correlata iniziativa utile e necessaria nei riguardi di tutti gli enti, con
altre associazioni, imprese pubbliche e private, istituti di istruzione di
ogni ordine e grado, università, collettività.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da donazioni, lasciti siano
essi di fonte privata e/o pubblica e dalle eventuali eccedenze di
bilancio. Le entrate sono costituite dai contributi dei soci promotori,
dei sottoscrittori, o di terzi, da sovvenzioni e finanziamenti dello Stato
e/o europei e di enti pubblici o privati; al fine di raggiungere lo scopo
sociale l’Associazione può richiedere finanziamenti e sostentamento ad
enti pubblici e privati.
Consiglio Direttivo:
BIANCOSPINO Cinzia
CIRCOSTA Giuseppe
DICHIERA Vincenzo
PENNA Adriana
PISCIONERI Romolo
RE Paolo
VASILE Mario Francesco
Cariche
Presidente
CIRCOSTA Giuseppe
Vice presidente
BIANCOSPINO Cinzia
Segretario
VASILE Mario Francesco
Tesoriere
RE Paolo
Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni
DI CHIERA Vincenzo
Responsabile Ricerche
Ass. Culturale La Memoria Rirtovata
RESPONSABILI PROGETTO
Enzo DiChiera - Pino Circosta
RESPONSABILE RICERCHE
Associazione La Memoria Ritrovata
ADDETTO STAMPA & PUBBLICHE RELAZIONI
Enzo DiChiera
IMMAGINE & GRAFICA
Cinzia Biancospino
RESPONSABILE ATTIVITA’ DI VOLO
Mario Vasile
RESPONSABILE CULTURA AERONAUTICA
Paolo Re